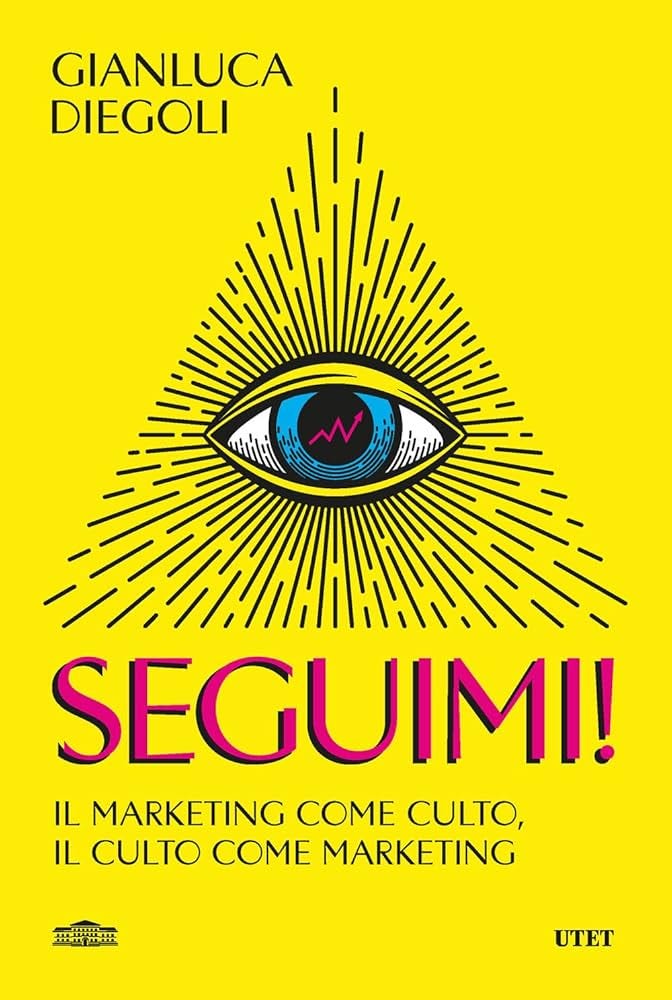[È venerdì] Tra padel e pacchi a sorpresa
E poi è uscito il mio nuovo libro
Questa è una newsletter un po’ diversa dal solito, perché è un po’ una trappola. Nel senso che non contiene il solito post originale, ma due miei pezzi che sono usciti da poco sul Post e su Link. Perché farvi aprire una cosa che forse avete già letto? Perché probabilmente non li avete per niente letti – ho calcolato che la probabilità che siate a conoscenza di entrambi è inferiore al 17%. Ognuno di noi pensa che gli altri leggano e sappiano tutto quello che facciamo. Niente di più falso, soprattutto nei tempi di iperframmentazione in bolle e circoletti. “Chi ci segue non è un biografo”, mi disse una brava, e me lo sono appuntato.
In ogni caso, ve li metto qua perché sono delle tracce sentite e sudate di un percorso personale di scrittura e di riflessione che va al di là di quello strettamente professionale. Un percorso che segue (follow the money) la parabola di un’umanità allegra e disperata, che vuole continuamente sfuggire all’angoscia del consumismo, ma così facendo si incastra in nuove trappole di consumo, solo vendute in nuovi packaging, che anziché vendere feature vendono community, connessioni, appartenenza.
Forse in questo momento storico ci sarebbero cose più importanti da narrare (guerre, disuguaglianze di ogni genere, clima…) e la maggior parte delle persone che non sono nella nostra bolla elitaria-occidentale sarebbero ben liete di dover/poter ricorrere agli acquisti compulsivi di pacchi misteriosi o di racchette da padel. Significherebbe che non ci sono problemi più urgenti da risolvere. Ma questo lo fanno meglio altre persone.
Il mio destino (e il mio eventuale talento) è evidentemente questo, quello di descrivere letterariamente (con una certa empatia, devo dire) le escrescenze del consumo, e a questo mi sono rassegnato – appena parlo di pianure divento noioso, lo so, non diventerò il prossimo Belpoliti. E di escrescenze di nuova generazione – ovviamente – parlerà anche il prossimo libro, di cui vi parlerò non appena il mio editor me ne darà il permesso. che si può già prenotare. (Siccome è su Amazon da poche ore, ve ne parlo la prossima volta). (Comunque la copertina è GIALLA!).
Sei tra le 25.603 persone iscritte tra qui, LinkedIn, Telegram e WhatsApp? Grazie di leggermi, spero che le ore per scriverla ti siano state utili.
Il quiz della settimana
Qual è stata la variazione del numero dei pranzi effettuati al bar in Italia nel 2024 rispetto al 2023?
Risposta corretta, come al solito, in fondo.
«IL TUO BRAND QUI»
A proposito, questa newsletter vive dello sponsor: informazioni, clic, idee e costi qui. Ci sono ancora slot a maggio e giugno. Scrivimi a gluca@diegoli.com
Come il padel si è mangiato tutto
«La mia teoria della tracimazione indica che i trend che debordano in provincia diventano inarrestabili.». Ma è anche una storia da insegnare ai manager.
Questo articolo è stato pubblicato nella sezione Storie/Idee de Il Post.
C’è un modo empirico per misurare i fenomeni economici, la loro ascesa e il loro declino. Se osservassimo una via dello shopping in fast forward, vedremmo il negozio di videocassette trasformarsi in un internet point, poi in un Money Transfer, quindi in un negozio di svapo, e infine in una vetrina fucsia di cover per smartphone. A ogni cambio di gestione corrisponde uno sgretolamento del sistema commerciale retrostante, che lascia spazio a un trend successivo.
C’è un metodo peculiare e definitivo che però è osservabile solo dalla provincia, almeno da quella padana da dove scrivo. Possiamo chiamarlo “tracimazione”. La città produce di continuo trend commerciali, normalmente nel settore dell’intrattenimento, della moda e della ristorazione. Molti sono di breve durata, magari anche di successo, ma seguiti da un rapido riflusso – per esempio, i luoghi dedicati a poke, burger gourmet o bubble tea. Alcuni trend non avvicinano nemmeno il margine della diga: la pizza gourmet, il ramen e la pasta in bianco d’autore, per esempio, sono rimaste ferme, più o meno. Altri fenomeni invece rompono gli argini – da cui la tracimazione – e cominciano a inondare la provincia. Ci hanno inondato, in ordine sparso, il sushi, le yogurterie gelato, il kebab.
Da un po’ di tempo in qua, tutti i miei radar rivolti alla sociologia umana rilevano cose di padel. I parenti che si accordano per una partita prima del panettone natalizio, le notizie locali di inaugurazioni di campi, quel capannone lato statale dismesso della zona artigianale che all’improvviso si illumina di una grande insegna con la racchetta al neon visibile a un chilometro di distanza, con un’estetica a metà tra night club e bowling.
La tua è diventata un’ossessione, insinuano gli amici. Forse perché sono rimasto l’unico a non giocarci? Potrebbe in effetti trattarsi del famigerato effetto Baader-Meinhof (o anche illusione di frequenza), che si verifica quando qualcosa che ci interessa inizia a comparirci ovunque, perché la nostra attenzione è inevitabilmente selettiva. E se invece fosse la conferma che il padel sta diventando davvero un fenomeno infestante – e che non ce ne libereremo mai più?
La mia teoria della tracimazione indica che i trend che debordano in provincia diventano inarrestabili e tendenzialmente rimangono in auge per lungo tempo. Quanto al padel, il test empirico più semplice è vedere chi ci gioca. Se non sono solo gli inquieti iperattivi che a ogni stagione passano dal crossfit allo spinning e poi al calisthenics, ma gente come il tuo vicino di casa, tua cognata, tuo nipote, tutte tranquille persone senza grilli ginnici per la testa, allora il trend è già quasi mainstream. E per uno sport come il padel, che si gioca in quattro, l’effetto network è questione essenziale. È come per il telefono, i social network o WhatsApp: per essere soddisfacente la rete deve essere sufficientemente diffusa. Il valore non è in te, è negli altri.
Nel padel il principale ostacolo è riuscire a trovare in fretta una coppia di avversari, o anche un tris di giocatori, se non hai un compagno o una compagna fissa. Allo stato dei fatti, perfino qui, nel luogo più remoto della Pianura Padana, il padel ha superato il paradosso dell’uovo e della gallina, tipico dei trend emergenti e delle startup: perché uno sport si diffonda veramente deve essere praticato da un numero sufficiente di persone, ma finché non c’è abbastanza gente coinvolta è difficile che nuovi giocatori inizino a giocare. Attualmente pare che in Italia giochi a padel più di un milione di persone, ci siano 3.625 strutture che ospitano campi e 10.000 campi entro il 2025. Ma il dato più interessante è un altro: già nel 2023 si poteva giocare a padel in 1.544 comuni italiani, il 50% dei comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti. La provincia è stata effettivamente conquistata, partendo per una volta non dalla solita trendsetter Milano ma da Roma, dalla Sicilia, dal Piemonte.
La leggenda dei pescatori di pacchi a sorpresa
Comprare a scatola chiusa come forma di intrattenimento, un gioco consumista per acquirenti in cerca di nuovi stimoli, più che di oggetti utili. Dentro il fenomeno di King Colis, tra hype, mistero e desiderio di scoperta.
Questo articolo è stato pubblicato su Link.
“Ma secondo te, questa King Colis, è una cosa seria o no? Volevo andarci, a Bologna, ma sei tu che ne sai di queste cose” mi chiede la mia amica Annarita. Di solito io mi accorgo che un fenomeno è fuoriuscito dalla cerchia ristretta degli early adopter quando una persona che normalmente non si occupa di questioni di marketing ti fa domande in qualità di presunto esperto.
King Colis vende, sia online che in negozi affittati per l’occasione, le cosiddette “mistery box”, pacchi dal contenuto sconosciuto, ricavati – lo dichiara l’azienda – da spedizioni e-commerce andate smarrite, che così verrebbero salvate dal macero.
In pochi mesi di vita le ricerche per questa startup francese su Google sono schizzate, e le code per accaparrarsi una box sono diventate interminabili. Nel sistema darwiniano attuale dell’economia digitale il destino delle startup si biforca nettamente: da un lato, quelle che nonostante meriti e sforzi sono schiacciate nel silenzio dall’economia dell’attenzione, dall’altro, fenomeni che irrompono come un’invasione barbarica. Al cuore di questa asimmetria opera un paradossale intreccio di antagonismo pubblico e simbiosi privata tra influencer e media tradizionali. I primi, fungendo da avanguardia dell’attenzione collettiva, innescano una reazione a catena: i secondi, mossi dall’ansia di non perdere rilevanza (e traffico da Google), conferiscono legittimità istituzionale al fenomeno, riconsegnandolo poi all’ulteriore amplificazione dell’ecosistema influencer. Questo ciclo di risonanza continua ad alimentare la bolla speculativa dell’hype, di solito fino al suo inevitabile collasso. Ma andiamo per ordine.
King Colis fa parte di questa seconda categoria, e tutto questo è successo in poche settimane attorno all’inaugurazione del loro temporary store al centro commerciale RomaEst. Lo schema è stato il solito: gli influencer hanno raccontato live la loro esperienza cogliendo l’occasione per un unboxing dal centro commerciale, i quotidiani locali hanno annunciato con grande enfasi le aperture, poi i giornali nazionali si sono affrettati a intervistare le persone in fila per cercare di capire se si fosse in presenza di persone furbe o sprovvedute (in realtà facendo risaltare più che altro la lunga fila, che come si sa è un potente strumento d’attrazione, l’economia comportamentale la chiama social proof, o riprova sociale) e infine i magazine di lifestyle hanno espresso opinioni variegate che andavano dall’eccitato al sospettoso. In ogni caso nelle dinamiche attuali di comunicazione, l’andreottiano “purché se ne parli” è ritornato prepotentemente di moda. Soprattutto se c’entra un algoritmo.
Se King Colis fosse un farmaco e potessimo leggerne il bugiardino, potremmo facilmente scoprirne sia la posologia (per le folle) che gli effetti collaterali (sui media) che ne hanno determinato l’esplosione. King Colis è l’antidepressivo perfetto per il consumatore contemporaneo.
Comprare a scatola chiusa, al contrario di quello che sostiene quella pubblicità, ci piace. È l’effetto che cerchiamo nelle mystery box. L’attesa aumenta l’ansia, che rende più inebriante il successivo effetto sorpresa. E poi c’è la scoperta: che bello è quando è l’oggetto a rivelarci il bisogno (e non il contrario) come quando i lontani parenti, per una volta, indovinavano il regalo giusto per noi senza averlo chiesto a Babbo Natale? Non sapevamo di volere quella macchinina telecomandata, ma in effetti… Poi c’è l’azzardo, il rischio di prendere una fregatura, ma anche il sogno di fare l’affare da raccontare. Per quanto noi del ventunesimo secolo possiamo essere diventati razionali, il richiamo dell’azzardo indolore (quello dal sapore antico della pesca di beneficenza dell’infanzia) è evidentemente qualcosa a cui non riusciamo a sfuggire. Fa tutto parte di bias mentali inconsci, innestati a un livello profondo della coscienza. Ed è una contraddizione affascinante: nell’era dell’iper-informazione, in cui con una ricerca possiamo sapere tutto di un prodotto, dalla composizione alle recensioni, sembriamo riscoprire il valore dell’incertezza, un’esperienza di vulnerabilità condivisa che, oltretutto, ci riconnette, ci fa fare amicizia nelle code e nei thread, attraverso l’attesa forzata – anche questa condizione sempre più rara nel flusso incessante della comunicazione digitale.
Il marketing insegnato dai negozianti
Alla fine ha ceduto allo zabaione.
ilmarketinginsegnatodainegozianti.info è un progetto collettivo di gonzo journalism a cui puoi contribuire senza pietà. No screenshot o inoltri dai social, solo foto tue.
Segnalazioni
La scorsa settimana ho parlato del business della musica terapeutica automatizzata.
Ho letto 'This is Strategy' di Seth Godin e ne discuto con Giuseppe Stigliano in 45 minuti: tra presunte mucche viola e community che funzionano davvero. Si ascolta con calma qui.
That’s all folks!
Se ti è piaciuta, inoltrala o stampala sulla stampante condivisa dell’ufficio, qualcuno la raccoglierà. Ah, se stai pensando di supportare questa newsletter, clicca qui. Se stai pensando a un workshop interattivo nella tua organizzazione o a uno speech al tuo evento, scrivi a gluca@diegoli.com o rispondi direttamente alla mail.
Ci leggiamo venerdì prossimo,
gluca
Grazie a Daniela Bollini per la paziente correzione e il commento aggiunto:
Questa cosa dei pacchi sorpresa già l'avevo sentita, ogni tanto mi esce la pubblicità su internet di comprarne uno (no, grazie). Mi ricorda tanto una cosa della mia generazione: quando facevo le elementari (tipo 1988/1990) in edicola per noi bambini c'erano delle grandi buste colorate di plastica, non trasparenti, che contenevano cose misteriose per bambini spacciate per superdivertenti, mai esplicitamente scritte all'esterno sulla busta. Gli adulti ci compravano queste buste per le grandi occasioni, ad esempio quando andavi al mare in vacanza o, nel mio caso, la singola volta all'anno che andavamo a Milano città. Il contenuto era quasi sempre molto deludente: qualche foglio da colorare con guida su come colorare, qualche ninnolo inutile di plastica che finiva dritto nella pattumiera, una trottola o una matita sarebbe state un lusso impensabile. Chissà se ci sono ancora quelle bustone nelle poche edicole superstiti. Vabbè, questo per dirti che mi sa che un po' di quei bambini ora sono cresciuti e si comprano direttamente le scatole di King Colis. Fine divagazione della mia infanzia.
E grazie a Cristina Portolano per i separatori.
Quiz: c) +1% (fonte Bargiornale e Tradelab).
![Il venerdì di [mini]marketing](https://substackcdn.com/image/fetch/$s_!vuky!,w_40,h_40,c_fill,f_auto,q_auto:good,fl_progressive:steep/https%3A%2F%2Fsubstack-post-media.s3.amazonaws.com%2Fpublic%2Fimages%2Ffd6be18f-4b0e-47da-9179-9f32052c5bcb_554x554.png)