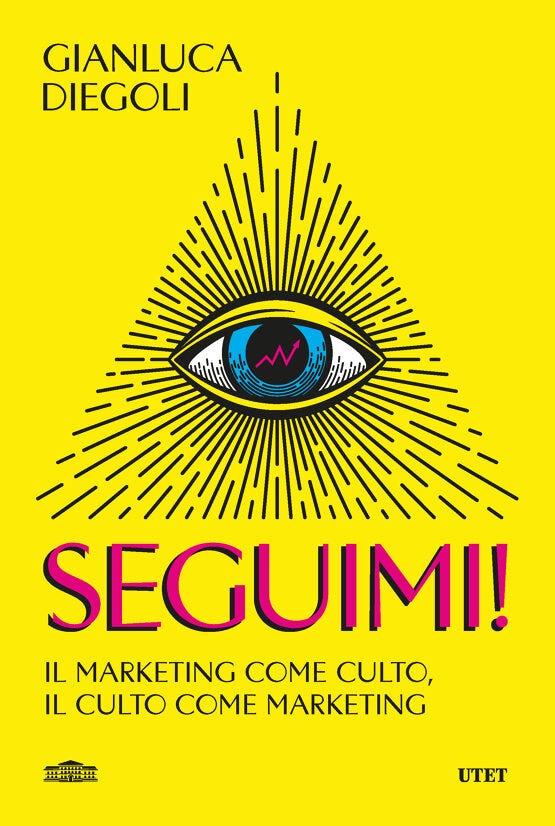☀️[È venerdì Summer Edition] Reportage dei miei quattro giorni in un borgo appenninico
Il modello di businessi dei borghi non così più belli d'Italia. E un nuovo crucimarketing
Sei nella versione estiva e un po’ svagata di questa newsletter. La normale programmazione torna a settembre. La scorsa settimana ho scritto del turismo al Lago Più Piccolo d’Emilia, e oggi del mio soggiorno estivo in un borgo.
Come ogni anno, ho passato qualche giorno in giro da solo. Ho preso un posto isolato, a caso, su Booking, e via che sono andato. Sulle colline parmensi, per la precisione. L’Appennino emiliano è un posto bastardo: non montagna da turismo vero, non provincia da business moderno, non pianura da agricoltura intensiva, nemmeno collina da cartolina toscana, ignorato da inglesi e tedeschi. È rimasto lì così, indeciso su cosa fare. Tante seconde case, lasciti di avi partiti per la Padania piatta o la città, alcune rimesse a nuovo con aggiunta di piscina se i discendenti hanno fatto fortuna, in caso contrario malandate e un po’ rappezzate alla meglio, come se fossero appartamenti di periferia semplicemente spostati per qualche mese a qualche centinaio di metri di altezza.
Il paese collinare capoluogo comunale è sempre quasi uguale, da Piacenza fino alle Marche: ci sono un ristorante fermo agli anni ‘70 come il suo menù e gli infissi in alluminio, un negozio di specialità locali che però espone in vetrina anche la pasta Barilla e il latte Granarolo (che sono comunque corregionali, in effetti), la gelateria per far sfogare i ragazzini, un bar di anziani (quelli rimasti e quelli ritornati si uniscono nel lamento) in cui c’è spesso in bella vista una rabbiosa La Verità o una passiva-aggressiva pagina locale del Carlino, come oggetto che innesca la discussione. La montagna ti rende diffidente dai foresti, e il mondo, da lì, sembra impazzito davvero. “Però George, lo spazzino, è bravo” (nonostante sia foresto, appunto). Del resto, lo sporco da ramazzare è davvero poco, quando ci si conosce tutti e buttare una cicca in terra ti fa lo stesso effetto che buttarla nel tuo salotto di casa. L’età media è molto alta, come in Florida, ma senza i soldi.
In questi posti la gente ti osserva, e tu osservi la gente. “Che ci fai qui?”, leggo negli occhi (ma spesso anche nel fumetto a voce) della ragazza barista/cameriera stagionale che non vede l’ora di ri-scappare a Parma – di sicuro sta chattando con le amiche che sono già a Riccione. Sì, perché non sembro un pellegrino (cioè un camminatore della Via Francigena, o della Via degli Dei, o di chissà quale altra leggenda pedonale rivitalizzata dalla locale pro loco e dal passaparola di coloro che vogliono trovare se stessi faticando come muli per una settimana). Non ho infatti la maglietta colorata antisudore e lo zaino, nemmeno una cartina geografica vintage di carta in mano. Non ho nemmeno camicia e pantaloni lunghi, quindi non posso essere il nuovo bancario mandato per punizione alla locale agenzia o un venditore di case impossibili da vendere, anche se è riuscito a far inserire (pagando il giornalista e/o il giornale, non ha capito bene) il suo paese nella classifica dei 1.000 borghi più belli d’Italia, pubblicata ad agosto da un settimanale, alla posizione numero 832.
In ogni borgo appenninico dotato di sufficienti tornanti sfilano i motociclisti che per qualche ragione che personalmente non comprendo (cioè sì, ma no) si divertono tantissimo ad andare su e giù per le montagne sgasando e piegando, ogni tanto finendo in dirupi o schiantandosi in frontali contro i pickup degli abitanti locali. Ma, appunto, a sera (se sono vivi) se ne tornano a casa. Lasciano più inquinamento che soldi, credo. Forse i comuni dovrebbero trasformare i loro tornanti in parco giochi per motociclisti ossessivi con tanto di biglietto, un nuovo skipass estivo, visto che lì la neve non si vede da venti anni, e non si sa che fare con quell’impianto arrugginito.
Di solito in ogni paese c’è una rovina locale risalente a una o più guerre di bande nobiliari del passato: una torre, un castelletto, di solito distrutti nel 1500 per dispetto dai seguaci del duca del paesello accanto, e poi usati come comodo deposito per estrarre materiale edile a costo zero. (Il rudere se fosse per dire a Cipro sarebbe meta di pellegrinaggio turistico di inglesi e russi. Se fosse in Croazia (o a San Marino) da quelle due pietre residue ci ricostruirebbero sopra Camelot e organizzerebbero una sceneggiata in costume.) Qui di solito la rovina è chiusa alla visita perché il custode volontario ha quasi cento anni e quando potresti visitarlo lui sta riposando (non ancora per sempre).
Poi ci trovi anche gente fuori da ogni logica, come il padrone di casa del B&B, inglese, che trasforma case malmesse in mezzo alla collina in appartamenti e piazzole da campeggio, riuscendo così a fuggire dal capitalismo fordista del nord dell’Inghilterra per diventare prigioniero del capitalismo delle piattaforme digitali (“lasciami la recensione!”), e affittarle a turisti, rigorosamente nordici, di passaggio.
Una sfida, visto che la maggior parte degli alberghi sono in vendita e/o chiusi da anni, simbolo di un passato in cui per andare in villeggiatura ci si accontentava di fare quaranta chilometri. Ma lui sembra felice, chissà cosa si è lasciato dietro. Qui però ha messo un Wi-Fi potente, e perfino Netflix sulla tv. L’ho guardata un attimo, quasi solo per dargli soddisfazione, e lasciare una traccia dei miei gusti mediatici nella cronologia condivisa dello streaming.
Poi ci sono le amministrazioni locali: il Comune è rigorosamente governato da una lista civica con simbolo tipo aquila (anche se lì, l’uccello in questione, non si è visto, almeno negli ultimi duecento anni) o frutto di bosco a caso (specialità locale invariabilmente da rivalorizzare), che si è data da fare a suo modo per illustrare le ricchezze del territorio. Di solito ha piazzato anni fa dei QR code sui monumenti (a volte questi scaricano illeggibili PDF scritti in caratteri minuscoli, a volte invece il link punta nel vuoto digitale dopo che il dominio del sito non è stato rinnovato).
La Provincia, come ultimo atto prima di essere stata abolita (ma non si sa bene: la provincia in Italia è una specie di zombie che non muore mai) ha affisso cartelli stradali che indicano la direzione de “La Strada Dei Sapori” ma nessuno sa dove porti o da dove arrivi questa strada, e nemmeno perché dovresti seguirla.
Ogni tanto apre l’attività in autoproclamata nuova gestione di quelli che dalla città volevano scappare, hanno visto l’affitto a 100 euro al mese e hanno pensato “ma se aprissi…”: la continuazione dalla frase è solitamente un birrificio artigianale, un agriturismo bio-ecologico e sostenibile, un ristorante veg con 10 coperti, un atelier di ceramica, ecc. ecc. Di solito si stancano dopo poco — dopo che tutti gli amici cittadini gli hanno fatto visita e non sono più tornati – e lemmi lemmi sgusciano di nuovo in città. Alla gente piace cullarsi con lo storytelling de "i piccoli borghi”, della vitalenta, ma poi si accorge che sono due palle e scappa a Formentera.
Quelli al bar con La Verità in mano (nel senso, con il giornale in mano) si dicono senza dirlo, solo guardandosi, “te l’avevo detto”.
Poi c’è l’imprenditoria locale: di solito c’è almeno un ricco del paese (ultimo e lontano discendente del trisavolo latifondista, bisnonno precedentemente podestà, imparentato con l’ex conte del suddetto castello non visitabile, ecc. ecc.) che gestisce già il negozio universale con tutte le licenze (può vendere dai pallettoni da fucile fino allo gnocco fritto – o torta fritta, per la bizzarra denominazione locale).
Da qualche anno ha aperto un noleggio ebike, sfruttando un ennesimo bando di rivitalizzazione economica, regionale e/o europeo. Non che abbia bisogno di soldi, potrebbe vendere le sue proprietà in paese un pezzettino alla volta e la sua famiglia sopravviverebbe per 500 anni allo sciallo. In realtà ha aperto l’attività per divertirsi ad andare su e giù dal paese con questa Tesla a due enormi ruote e fare mansplaining alle turiste olandesi sul valore culturale del ricco territorio in cui si trovano a passare.
“Così finalmente abbiamo la montagna ma con la comodità della pianura”, dice. E io, in fondo, sono pure d’accordo con lui.
Anche questa settimana, poi forse basta, c’è il cruciverba di marketing.
Quindi potete scaricare il nuovo PDF del cruciverba, stamparlo e portarlo in spiaggia, oppure cercare di risolverlo online (non garantisco si veda da smartphone).
Se invece volete passare vacanze spensierate, e al marketing pensarci solo a fine agosto, qui sotto c’è il mio ebook Cose divertenti. È anche gratis.
Ma se volete proprio sorridere sotto l’ombrellone e spaventare i vicini, c’è il libro giallo. Qui potete leggerne un capitolo, pubblicato da Link.
Ho inoltre fatto quattro chiacchere sul libro e sul marketing per il podcast video di Vincenzo Cosenza. Ecco qua la puntata.
Ci si sente quando capita. Buon agosto.
Ciao,
gluca
E grazie a Daniela Bollini per l’editing: secondo me a lei l’Appennino piacerebbe. (In realtà, dice di no).
![Il venerdì di [mini]marketing](https://substackcdn.com/image/fetch/$s_!vuky!,w_40,h_40,c_fill,f_auto,q_auto:good,fl_progressive:steep/https%3A%2F%2Fsubstack-post-media.s3.amazonaws.com%2Fpublic%2Fimages%2Ffd6be18f-4b0e-47da-9179-9f32052c5bcb_554x554.png)